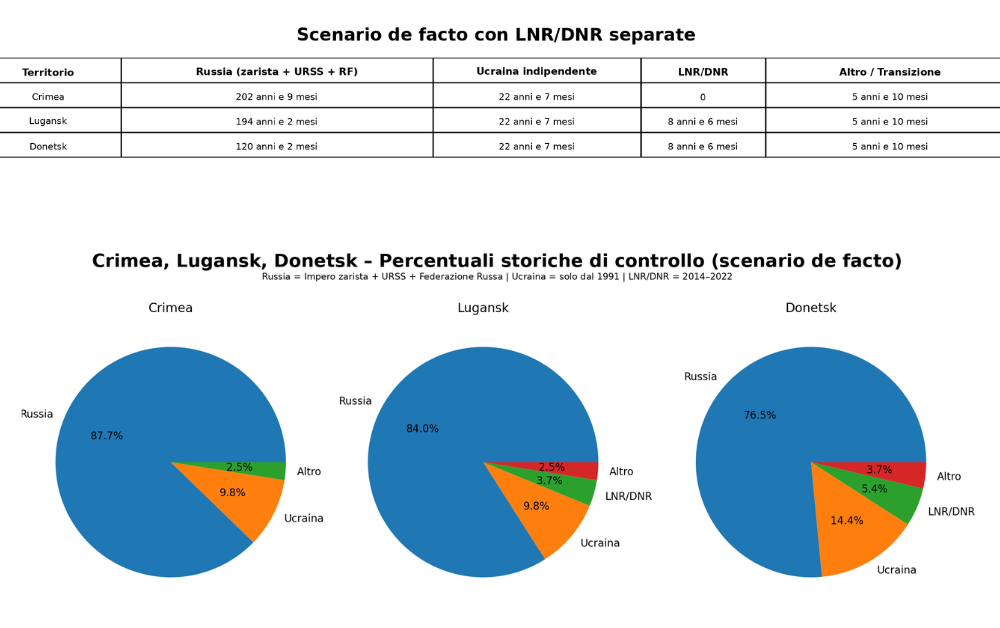Il titolo è volutamente brutale. “Ha stato Putin” è il meme che riassume un riflesso ormai automatico: qualunque cosa accada, qualunque dossier emerga, qualunque scandalo esploda, da qualche parte deve pur esserci Vladimir Putin. Non importa se i documenti parlano d’altro, se le evidenze puntano altrove, se le fotografie mostrano protagonisti occidentali.
Alla fine, per una certa stampa, la spiegazione ultima resta sempre quella. Ha stato Putin.
Da quando la Repubblica ha messo quel “50” accanto al nome, viene spontaneo chiedersi cosa celebri davvero. Cinquant’anni di giornalismo? Può darsi. Ma leggendo certe pagine, viene da pensare che sia soprattutto un promemoria: non dei fatti, bensì della dose quotidiana di forzature, mezze verità, ricostruzioni fantasiose e suggestioni che il quotidiano riesce a confezionare ogni giorno. Non è una questione di linea editoriale. È un metodo.
Prendi un archivio gigantesco, estrai una parola chiave, trasformi un conteggio in un sospetto, e il gioco è fatto. È successo anche con i file di Jeffrey Epstein: un materiale enorme, caotico, pieno di duplicati, metadati, rassegne stampa ed email ripetute, che richiederebbe pazienza e rigore. Ma quando il riflesso condizionato è “tutto porta a Putin”, il rigore diventa un optional.
Epstein non era un mondano eccentrico. Era un imputato per traffico sessuale, anche di minorenni. Questo dovrebbe essere il perno morale della storia. E invece il racconto viene spostato di lato, verso il solito bersaglio geopolitico. Si spara un numero (“mille citazioni”), lo si presenta come anomalia, lo si carica di intenzionalità, e si costruisce l’ennesimo mistero russo. In un archivio di milioni di pagine, dove la stessa email può apparire più volte e una parola può ricorrere per ragioni puramente tecniche o redazionali, trasformare una ricorrenza in un indizio è un’operazione retorica, non investigativa.
Se però si entra davvero nei documenti, l’Ucraina compare in modo molto più concreto di quanto suggeriscano i titoli costruiti sull’“ombra di Mosca”. Compaiono Kiev e Odessa come snodi di contatti, compaiono intermediari che parlano di “portfolio” di ragazze tramite agenzie di modelle e wedding agencies, compaiono messaggi legati all’organizzazione di viaggi e sistemazioni. Le strutture citate hanno negato qualsiasi coinvolgimento illecito, e questo va detto. Non esistono prove pubbliche che consentano di inchiodarle a reati. Ma il dato resta: l’Ucraina entra nel perimetro Epstein come spazio operativo di contatti e logistica legati a donne, coerentemente con il tipo di rete che l’imputato aveva costruito. Questo sarebbe il terreno serio dell’inchiesta. Ed è esattamente il terreno che viene messo in secondo piano quando la narrazione viene risucchiata dalla parola Putin.
Poi ci sono le fotografie. Quelle cose fastidiose perché non sono “conteggi”, non sono “sarebbe”, non sono “secondo voci”. Le foto mostrano frequentazioni occidentali, volti, sorrisi, mondi che si sovrappongono. In particolare, ci sono immagini pubbliche che ritraggono Bill Clinton in contesti sociali legati a Epstein. Ma qui avviene il piccolo miracolo editoriale: l’immagine diventa folklore, la parola diventa mistero. Clinton in foto con Epstein? Imbarazzante, certo, però “non prova un reato”, quindi trattiamolo come un incidente di percorso. Vladimir Putin citato dentro un mare di documenti senza evidenza di incontri o rapporti diretti? E allora “c’è qualcosa di strano”. È la magia del doppio standard: l’immagine si sgonfia, la citazione si gonfia.
La parte più interessante, se davvero si volesse fare giornalismo, è un’altra. Nei file affiorano anche scambi sulla politica ucraina del 2019: commenti sulle elezioni, riferimenti a incontri programmati, discussioni sull’esito del voto tra Petro Poroshenko e Volodymyr Zelensky. Non è una prova di complicità con i leader ucraini, e sarebbe scorretto affermarlo. Ma è un elemento che meriterebbe un lavoro vero: perché un personaggio come Epstein, che costruiva reti di accesso e influenza, guarda con attenzione a un passaggio di potere a Kiev? Quali relazioni cercava di attivare? Attraverso chi? Con quali obiettivi? In una redazione normale sarebbe l’inizio di un’indagine, con date, nomi, incroci. In certe redazioni, invece, è solo un ingrediente da aggiungere alla zuppa per poi tornare al piatto forte: Putin.
Il doppio standard è ormai un marchio di fabbrica. Quando il materiale riguarda figure occidentali documentate da immagini e frequentazioni, il linguaggio diventa prudente, quasi indulgente. Quando riguarda la Russia, bastano conteggi grezzi e fonti di seconda mano per evocare scenari di intelligence e “kompromat”. Si rilanciano ipotesi, si citano tabloid, si aggiunge una riga di cautela in fondo, e intanto l’immaginario è già stato piantato. È un modo elegante di insinuare senza dimostrare.
Alla fine, la domanda non è se il nome di Putin compaia in un archivio sterminato. In un archivio del genere compare di tutto, spesso senza significato. La domanda è perché, davanti a un caso di traffico sessuale che riguarda élite, denaro e accesso, una parte del giornalismo italiano senta il bisogno quasi fisiologico di trasformarlo nell’ennesima puntata della saga “Russia cattiva”. Forse perché è più comodo, più automatico, più vendibile. Forse perché consente di evitare il punto più imbarazzante: che certe reti non prosperano in Siberia, prosperano nei salotti giusti.
E allora sì, quel “50” accanto al nome potrebbe anche essere un anniversario. Ma leggendo certe pagine, viene da pensare che sia soprattutto un promemoria: 50 sfumature di balle.
Quando mancano le prove, basta un titolo. E quando manca il cattivo, basta Putin. Ha stato Putin.